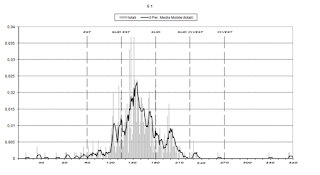di Franco Laner
La risposta all’evidente constatazione che le statue di MP
non possano stare in piedi me l’ero fatta ed ora disfatta. Duro rigettare ciò
che mi pareva plausibile e sostenibile fino a maturare un’altra congettura, ma
i recenti reperti del 2014 mi inducono a riformulare l’ipotesi.
Se qualcosa non sta in piedi, questo era il ragionamento che
mi ha portato all’ipotesi di telamoni, gli faccio agire una sollecitazione di
compressione, in pratica un carico superiore, concentrato e stabilizzante, per
esempio quello dato dall’architrave. Ma gli scavi fin’ora non hanno restituito
resti di tempio (qualche fusto di colonna o capitello, mi pare, ma li chiamano
modelli di nuraghe!) o altre strutture. L’equilibrio potrebbe essere fornito da
una qualche “stampella”, ma non ci sono segni di protesi, muri, agganci,
legature, sostegni
Ci sono molte forme di innamoramento. La più usuale è quella
nei confronti di altre persone, un luogo, una teoria. Pericoloso
l’innamoramento collettivo verso un’ideologia o religione. Pericoloso perché
porta all’intolleranza, all’integralismo, al fanatismo. Ci si innamora appunto
anche di una ipotesi, perché ritenuta intelligente, esplicativa, bella o
singolare. Oppure semplicemente perché soddisfa la nostra ambizione e perciò
rigettarla non è né facile, né semplice.
Per quanto il primo amore non si scordi mai, la mia ipotesi
di telamoni deve lasciare il passo ad una nuova congettura.
L’ipotesi (non una teoria) che ho avanzato recentemente su
questo blog sui guerrieri di MP fa seguito appunto all’ipotesi di telamoni che
sostenni per risolvere la questione che ancora non ha risposta: le statue, così
riassemblate ed esposte, non possono stare in piedi. Se non possono stare in
piedi non sono allora mai state messe in piedi. Ma perché dovrei fare statue
destinate a non stare in piedi? E’ inipotizzabile, assurdo e pertanto tutti
pensano che siano state messe in piedi. Ovviamente anche i due scultori,
Rockwell e Mondazzi. Perciò, pur non capendo come si reggessero, si prodigano
nella ricerca di sostegni o ipotizzando pareti, muri, sostegni rimossi, buchi,
agganci ecc.: non ci sono risposte o segni e alla fine si meravigliano e lodano
la grande capacità e perizia di chi è riuscito nell’impresa. Peccato che questa
affermazione sia ritenuta come prova determinante per l’esaltazione e la
priorità mediterranea delle statue di MP!
Anch’io, pensando a telamoni, schiacciati superiormente
dall’architrave, in fin dei conti cercavo una soluzione perché non ho mai,
nemmeno lontanamente, pensato che non siano state collocate in piedi.
Se alla fine sono giunto ad altra conclusione è perché la
trovo consequenziale a quanto conosco sui reperti, luogo, risultati, deduzioni
archeologiche, ecc. ecc.
L’ipotesi, in altre parole, è dettata dalla mia immaginazione,
non dalla fantasia (parte patologica dell’immaginazione), che
cerca di mettere insieme indizi. Spesso, specie nei blog, si legge e si scrive
in fretta e distrattamente e non si pesano le parole. Ad esempio non ho mai
parlato di falso, bensì di rimessa in bella, ritocchi, aggiustamenti. Falso
significa che è stato rifatto ex novo. Certamente se il ritocco è profondo,
autoreferenziale, rasenta il falso, pur essendo il materiale autentico. Ancora,
gli indizi che posseggo sono limitati e
quindi anche la deduzione è più difficile. Un conto è ragionare su foto,
resoconti, descrizioni, altro è vedere e toccare. A Monte Prama ci sono stato
prima degli ultimi scavi e ho visto solo le lastre di chiusura di alcuni
pozzetti. Ho visto il luogo, non gli scavi. Ho visto i guerrieri esposti a
Cagliari e tre volte sono stato a Li Punti.
Rileggendo le critiche che mi vengono avanzate, capisco solo
che la reciproca comprensione è una chimera. Ad esempio Francesco Maxia mi
obietta che non sia possibile che tutto “questo ben di dio” sia stato buttato
in discarica. Ma questo è un giudizio soggettivo ed enfatico. Per il contadino
era solo un “mal di dio” e forse lui stesso l’ha buttato in discarica per
spietrare il terreno. Può essere stato un “mal di dio” anche per gli
scalpellini…
Lo stesso Maxia mi chiede lumi sulla scelta del luogo. Pur
non capendone la finalità o come si relazioni all’ipotesi che ho avanzato posso
dire di una categoria che il luogo debba possedere: essere più in basso della
cava. Anche la discarica è preferibile che sia più in basso del luogo di
lavorazione. Spero di non dover spiegare perché! I reperti delle statue sono
più in basso della cava e la discarica più in basso delle tombe. Estratto il
masso da cui ricavare la scultura, si può agire o sbozzando il masso in cava
per rendere più agevole il trasporto (perciò nasce la stereotomia) o
trasportando il masso -o il masso sgrezzato- laddove troverà posto in opera. Il
posto di collocazione della statua finita è la dove c’è già la presenza delle
tombe, che sacralizzano il luogo. E’ un luogo che presumibilmente si voleva
fosse meglio identificato, con un tempio, con una più forte consacrazione, o
migliore riconoscimento. C’è già un’area sacra, non profana. Perché non lì?
Mondazzi pensa che la statua possa essere stata scolpita in
piedi, proprio perché, a causa della sua fragilità scultorea (attenzione, non
solo statica) non è facile spostarla sul fianco o rigirarla. Comunque non è
facile nemmeno l’operazione scultorea pur con la statua in piedi. Si pensi solo
ai colpi necessari con la subbia per la sottrazione di materiale, fragile, per
le parti libere e sottili, come uno scudo, un arco o il braccio guantato
libero! Immagino che le ultime due statue venute alla luce nel 2014 -per
intenderci quelle col bubbone cangeroceno che Minoia definisce “scudo avvolto”-
non mi si venga a dire che siano state finite, o che gli scultori hanno
anticipato il “Non –finito” di Michelangelo o Rodin. Sono appena sbozzate e
pronte ad essere rifinite. Ma sono già rotte alle caviglie. Cosa te ne fai? Le
butti e provi con un’altra, cercando di far tesoro dell’esperienza negativa.
Se anche i successivi tentativi non approdano al risultato,
rinunci.
Certo, ho anch’io un sacco di domande senza risposta. Una
che mi intriga è come sia possibile possedere strumenti di ferro (subbie,
scalpelli, sgorbie, gradine) a detta dei due scultori, così raffinati da
permettere particolarissime lavorazioni con risultati così problematici, in
primis quelli statici, con carichi dissimmetrici rispetto ad una base risibile
che se sollecitata appunto con carichi eccentrici si rovescia spezzandosi nei
punti deboli. La risposta a questo problema è una sola: la Sardegna ha
preceduto di secoli la scultura mediterranea, pur non essendoci la minima
traccia nei ritrovamenti archeologici di strumenti scultorei così avanzati, né
di statue simili, né prima, né dopo. Mi chiedo se sia più attendibile questa
risposta o quella da me ipotizzata? Ma il mio tentativo nei casi migliori non
viene nemmeno giudicato, normalmente è ascritto alle stronzate di Laner. Ovvio
che mi piacerebbe che qualcuno entrasse davvero nel merito e mi facesse domande
o mi fornisse risposte o segnalasse errori nella logica del mio pensiero.
Mi si facciano dunque obiezioni più pertinenti, che sono
tali se si ha in mente una alternativa.
Invece ci si bea sulla produzione scultorea di una
“ragguardevole civiltà”, quale? Quella fenicia, quella nuragica o quale altra?
È davvero così strano o folle pensare che i nuragici, nei
loro viaggi, si siano portati qualcuno per farsi scolpire i guerrieri? O che
altri -esterni- abbiano tentato di identificare la loro presenza con i
guerrieri? Ci sono nell’Isola precedenti o posteriori casi di simile statuaria,
o meglio di una cultura o scuola in questo senso?
Anche Adriano -il più grande fra gli imperatori- per la sua
villa volle solo architetti, maestranze e soprattuttoscalpellini orientali.
Anche gli stupendi marmi della Villa vengono dall’oriente. Ne è stato sminuito
per questa scelta?
Infine potrei intervenire in Maymoni blog, visto che sono
chiamato in causa. Non mi considero degno, sinceramente, di entrare nel
“salotto” buono. Non ne ho il linguaggio, lo stile, l’educazione. Nel blog di
Mauro mi sento a mio agio. Se sostengo che nelle statue di MP non vedo arte, né
fenomenologicamente (v. Husserl o Merleau-Ponty) né emotivamente, vorrei
poterlo dire senza essere sbeffeggiato.
Oltrettutto se il maggior artista scultore sardo e non solo,
invita a guardare altrove, in Sardegna, per trovare l’arte e lasciar perdere
MP, non mi sento in cattiva compagnia. Dove ho visto l’arte mi sono prodigato
ad esaltarla e a valorizzarla, come per S. Cristina, qualche nuraghe, come Is
Paras, meglio Su Idili, di Isili, o Santu Antine -viceversa giudico modesto
Barumini e demenziali i rifacimenti arbitrari del monumento- o qualche
eccellente Tdi G. o l’emozione degli antropomorfi. Ancora invito a considerare
che sto parlando di architettura e arte, non di archeologia, retta da altre
categorie. E presuntuosamente dico che un po’ di estetica, per mestiere e
curiosità, l’ho metabolizzata.